Cultura
Sylvia Plath, Sarah Kane: una stessa storia?
Entrambe le poetesse hanno in comune l’essere vissute nel 900 ed essere morte suicide. Supporre che un’intelligenza autentica, degna di questo nome, non possa che respingere l’idea di autoinfliggersi la morte è una tesi che in questa sede non troverà cittadinanza e questo proprio a causa dell’elevato numero di coloro i quali chiamiamo genii e che hanno scelto liberamente di porre fine alla propria esistenza.
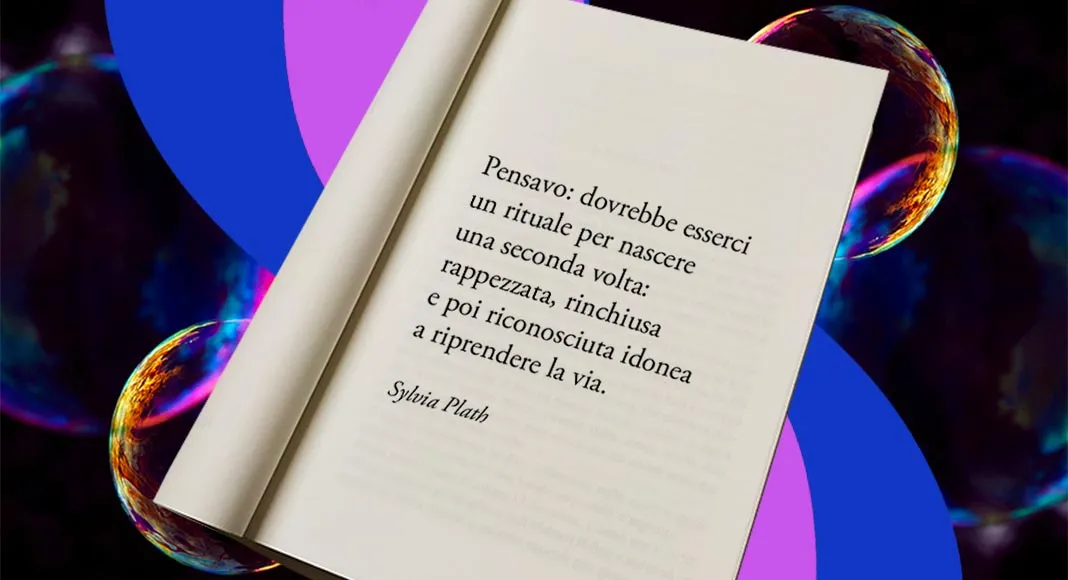
La poetessa e drammaturga Sarah Kane nasce a Brentwood, in Inghilterra, il 3 Febbraio 1971; morirà sucida a Londra il 20 Febbraio 1999, sue le parole:
“Non ho voglia di morire, nessun suicida ne ha mai avuta”.
Sylvia Plath, poetessa e scrittrice statunitense, nasce a Boston il 27 Ottobre 1932. Si toglierà la vita a Londra l’11 Febbraio 1963:
“… io sono il presente, ma so che anche io me ne andrò.
L’istante sublime, la fiamma che consuma, arriva e subito
scompare. Ed io non voglio morire”.
Le due poetesse citate hanno in comune l’ essere nate e vissute entrambe nel 900 e l’essere morte suicide. Prima di porci qualche domanda o semplicemente di guardare alle storie di queste donne, sarà opportuno che precisi che la scelta di scrivere di questo argomento non nasce da un interesse morboso per la fine che queste intellettuali hanno scelto per sé. Non leggerete infatti dettagli raccapriccianti che facilmente potrete trovare in rete, se di questo siete alla ricerca. Le parole che invece state per leggere sono motivate dal tentativo di avvicinarsi al dolore senza pretese chirurgiche, ma con la consapevolezze di affrontare una materia che, da un lato vede nel lavoro di queste donne un ineguagliabile e lucido contributo di civiltà e dall’altro sceglie di guardare oltreché alla grandezza ed al genio di tali figure, anche alla loro disarmante, irrimediabile fragilità, che pare non aver trovato uno spazio nel mondo in cui si son trovate a vivere.
Supporre che un’intelligenza autentica, degna di questo nome, non possa che respingere l’idea di autoinfliggersi la morte è una tesi che in questa sede non troverà cittadinanza, in primo luogo perché parlare di una intelligenza come se al mondo ve ne fosse una di un solo tipo è semplicistico e riduttivo e non risponde peraltro al vero, in secondo luogo perché basterebbe cambiare punto di vista per rendersi conto che ciò che a molti pare un’aberrazione, per altri potrebbe essere invece il naturale approdo di una vita guidata proprio da un’ analisi illuminata dall’intelligenza.
A sostegno di ciò basterà far menzione dei tanti geni di tutti i campi dello scibile umano, che in ogni tempo hanno deciso liberamente di togliersi la vita.
Ma tornando al discorso dal quale sono partita, nella biografia di una delle due figure citate, quella di Sylvia Plath, si legge che molto probabilmente più che un suicidio il suo fu una disperata richiesta d’aiuto che ebbe sfortunatamente un esito tragico (la Plath si premurò di lasciare un biglietto con il recapito telefonico del suo medico personale). È ovviamente impossibile sapere cosa la poetessa desiderasse davvero. Per certo sappiamo, poiché ella stessa lo scrisse, che si trattava del terzo tentativo di togliersi la vita in trent’anni.
Cosa può significare questo? Che desiderasse davvero la morte o solo attrarre l’attenzione su di sé? A mio giudizio ha senso credere che questa donna provasse un dolore talmente insopportabile, da pensare che la sola cosa che avrebbe potuto farlo cessare potesse essere la morte ed è ovvio che il grido di un essere umano è per sua stessa natura rivolto ai suoi simili, affinché lo aiutino a fermare il dolore. Vi è in chi soffre la consapevolezza che nessuno sarebbe in grado di porre fine al proprio supplizio? Allora è più probabile che non veda altra scelta che la morte. Val la pena di ricordare che la Plath fu poetessa di eccezionale talento e questo ovviamente a prescindere dalla fama che le è derivata dalla sua fine. Nei suoi versi vi è infatti una compiutezza estetica e di pensiero da pochi uguagliata ed una vitalità che non lascia presumere che l’esistenza della donna dovesse per forza di cose concludersi con un suicidio. È peraltro evidente nella sua poesia un “sentire” più forte, fatto questo che può diventare un elemento in grado di rendere intollerabile in certe condizioni l’esistenza umana.
Nella poesia ad esempio di Cesare Pavese si trova un’analoga compiutezza, ma una totale assenza di vitalità, di amore per la vita. Si tratta ovviamente di un’opinione del tutto personale, ma è come se Pavese fosse morto ben prima di aver compiuto il fatale gesto e la stessa cosa non è presente nella poesia di Sylvia Plath.
Anche Sarah Kane morirà suicida a Londra trentasei anni dopo la scrittrice americana. Le due sono figure artisticamente diverse: la Kane scrisse soprattutto opere teatrali, a differenza della Plath che fu poetessa nel senso più classico del termine. La prima ha fatto propri gli strumenti che il sessantotto ha creato: si esprime sempre liberamente e sempre in modo provocatorio ed il valore del suo contributo è indiscusso, oggi più che mai. Nonostante questa diversità, entrambe le donne, in modi differenti dichiarano espressamente di non voler morire, che nessun suicida vuole mai davvero morire. Sarah Kane in particolare scrive che a renderle insopportabile la vita è l’aver perduto l’amore:
“Tagliatemi la lingua
Mozzatemi gli arti
Ma lasciatemi l’amore
Preferirei aver perduto le gambe
Che mi avessero strappato via i denti
Cavato gli occhi
Piuttosto che aver perduto l’amore”.
Dunque anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un dolore in presenza del quale la morte pare preferibile e ad un grido, che è sempre naturaliter, richiesta di aiuto, anche di un aiuto che si sa di non poter ricevere:
” Nella vita non ho mai avuto problemi a dare agli altri ciò che volevano. Ma nessuno è mai capace di fare lo stesso per me”.
Colpisce, di questa donna che pure scrive che nessun suicida vuole mai davvero morire, che la sera stessa in cui ella cercò la morte e si riuscì a salvarla ed a ricoverarla, approfittando della momentanea assenza del personale, si impiccò utilizzando i lacci delle proprie scarpe.
Ha senso accumunare il suicidio della Kane a quello della Plath ed in generale, essendo la storia di ciascuno di noi una storia unica, possiamo dare il medesimo nome a morti che come elemento comune hanno la sola volontarietà? Sì, quando, come nei due casi presi in considerazione, ad esprimersi con parole ed accenti analoghi sono le dirette nteressate all’interno dei propri scritti, benché anche le parole siano convenzioni e la scelta che ciascuno di noi fa di esse, escluda le altre, rendendo per forza di cose parziale un racconto che invece rimane assolutamente originale ed irripetibile.
Rosamaria Fumarola.
RIPRODUZIONE RISERVATA ©

