Non categorizzato
Le “Vite parallele” di Plutarco, fonte inesauribile di storia antica
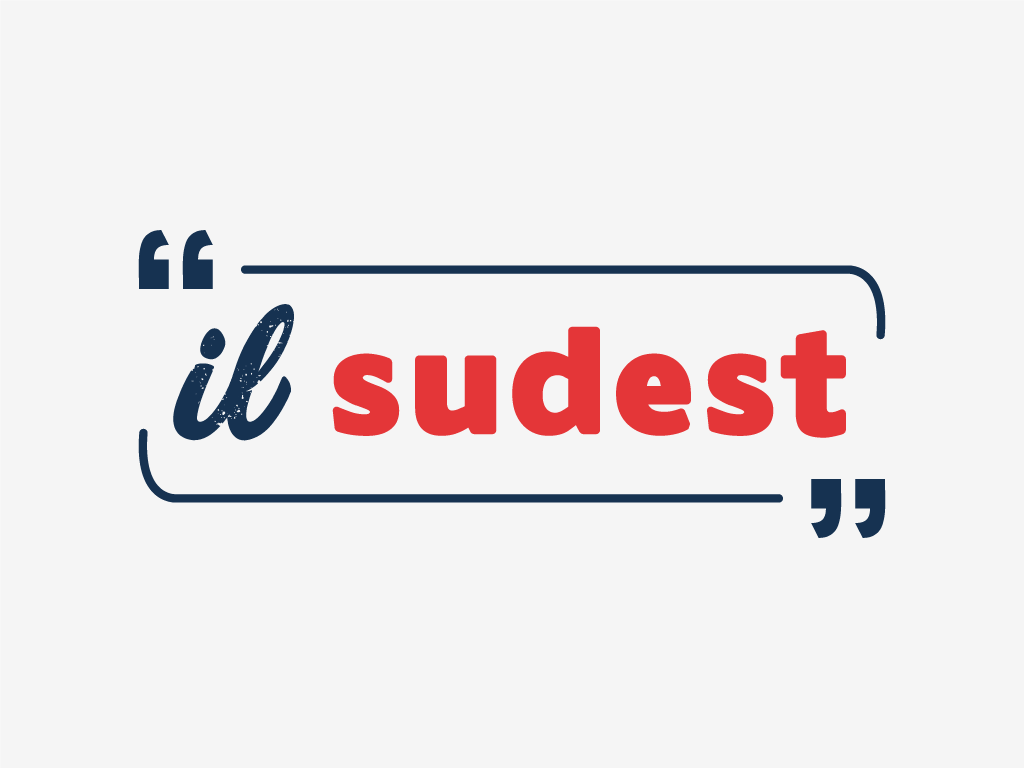
di MARIAPIA METALLO
Le vite parallele di Plutarco sono una fonte inesauribile di storia antica.Storia esposta con grande perizia letteraria e basata su un’intima e partecipata conoscenza del mondo ellenico e romano, del quale lo scrittore è un insigne rappresentante e un convinto sostenitore. La storia di Plutarco è storia aneddotica, nella quale i fatti minuti sono il microcosmo da cui si può “spiare” il macrocosmo, in base ad un rapporto analogico illuminato ermeneuticamente dallo scrittore: «Io non scrivo un’opera di storia, ma delle vite; ora, noi ritroviamo una manifestazione delle virtù e dei vizi degli uomini non soltanto nelle loro azioni più appariscenti: spesso un breve fatto, una frase, uno scherzo, rivelano il carattere di un individuo più di quanto non facciano battaglie ove caddero diecimila morti». Ovviamente si è molto discusso sulla plausibilità o fondatezza storica degli accoppiamenti proposti da Plutarco, e, in effetti, alcuni appaiono discutibili o forzati, però è indubbio che almeno in alcuni altri l’opzione plutarchiana appare illuminante: Alessandro e Cesare hanno davvero cambiato il mondo, Nicia e Crasso sono davvero i due grandi sconfitti, Demetrio Poliorcete e Marco Antonio sono davvero i trastulli della Fortuna e della passione erotica, Dione siracusano e Bruto fanno davvero della filosofia una pratica di vita, e, infine, Filopemene e Tito Flaminino sono davvero i tedofori di una certa idea dell’Ellade, in relazione alla potenza romana. Tutta l’opera è condotta all’insegna di un pacato razionalismo, sorretto dalla profonda condivisione dell’idea del giusto mezzo e del «mai troppo», dalla predilezione per un potere oligarchico “temperato”, lontano sia dalla demagogia cui è soggetta la democrazia, sia dalla tirannide (e si compiace di ricordare un arguto motto di Solone: «quello del tiranno è un gran bel posticino, ma manca di strada per discenderne»), e da una religiosità sobria ma non lassa. I valori plutarchiani sono l’ordine, la giustizia, la magnanimità, la laboriosità, la fortezza, la temperanza, l’equilibrio nell’accogliere la fortuna o la disfatta, ecc. ossia specificatamente i valori classici del logos opposto al caos. Nessun eroe, per quanto grande e virtuoso, è esente da vizi. D’ogni eroe, statista, stratega si narrano le grandi virtù, le imprese, le fortune e le disfatte, ma ad ognuno è assegnata anche una serie di vizi innati o emersi dall’evolversi delle loro esistenze. Per Plutarco diventa quasi un punto d’orgoglio o d’onestà intellettuale non mandare nessuno esente da pecche: Aristide, il grande politico e generale ateniese, non venne mai meno alla sua integrità morale, ma non seppe “scrollarsi di dosso la povertà”: anche la temperanza, la sobrietà, l’onestà stessa, praticate con cieca ostinazione, diventano un delitto contro il “giusto mezzo”. Plutarco esclude dal suo orizzonte speculativo e valoriale i sentimenti e la spiritualità individuale: l’uomo di Plutarco è l’uomo politico, è l’uomo della polis, è l’uomo che si giudica dagli effetti prodotti sulla comunità, è l’uomo dell’azione, non dell’intenzione. L’atteggiamento basilare di Plutarco riguardo agli eroi di cui si occupa è magnanimo ed equanime. Non infierisce quando si tratta di denunciarne i vizi e non si esalta quando si tratta di lodarne le virtù. Anche nella Vita di Giulio Cesare mantiene lo stesso atteggiamento moderatamente distaccato e politicamente equidistante, ma è curioso osservare che, fatta salva la parte dell’opera che lo riguarda direttamente, ogni volta che Plutarco si trova a coinvolgere Giulio Cesare raccontando altre vite assume un atteggiamento polemico e tutt’altro che accomodante. Tanto che si erge a difensore della memoria di Catone l’Uticense attaccato duramente dallo stesso Cesare in un suo scritto: secondo Cesare, Catone era così gretto e taccagno che dopo aver reso gli onori funebri al fratello rivestendolo d’oro e porpora, fece setacciare la cenere del rogo per recuperarne il prezioso metallo, e Plutarco insorge scrivendo: «fino a questo punto lo scrittore [Cesare] confidò che nessuno avrebbe controllato e analizzato ciò che usciva dalla sua penna, come ciò che eseguiva con la sua spada».

