08 Settembre 2025
Italia 2020: il bilancio delle misure anti-Covid
Dai primi Dpcm al sistema delle “zone”: cosa è stato fatto, cosa è mancato, cosa si poteva fare di più
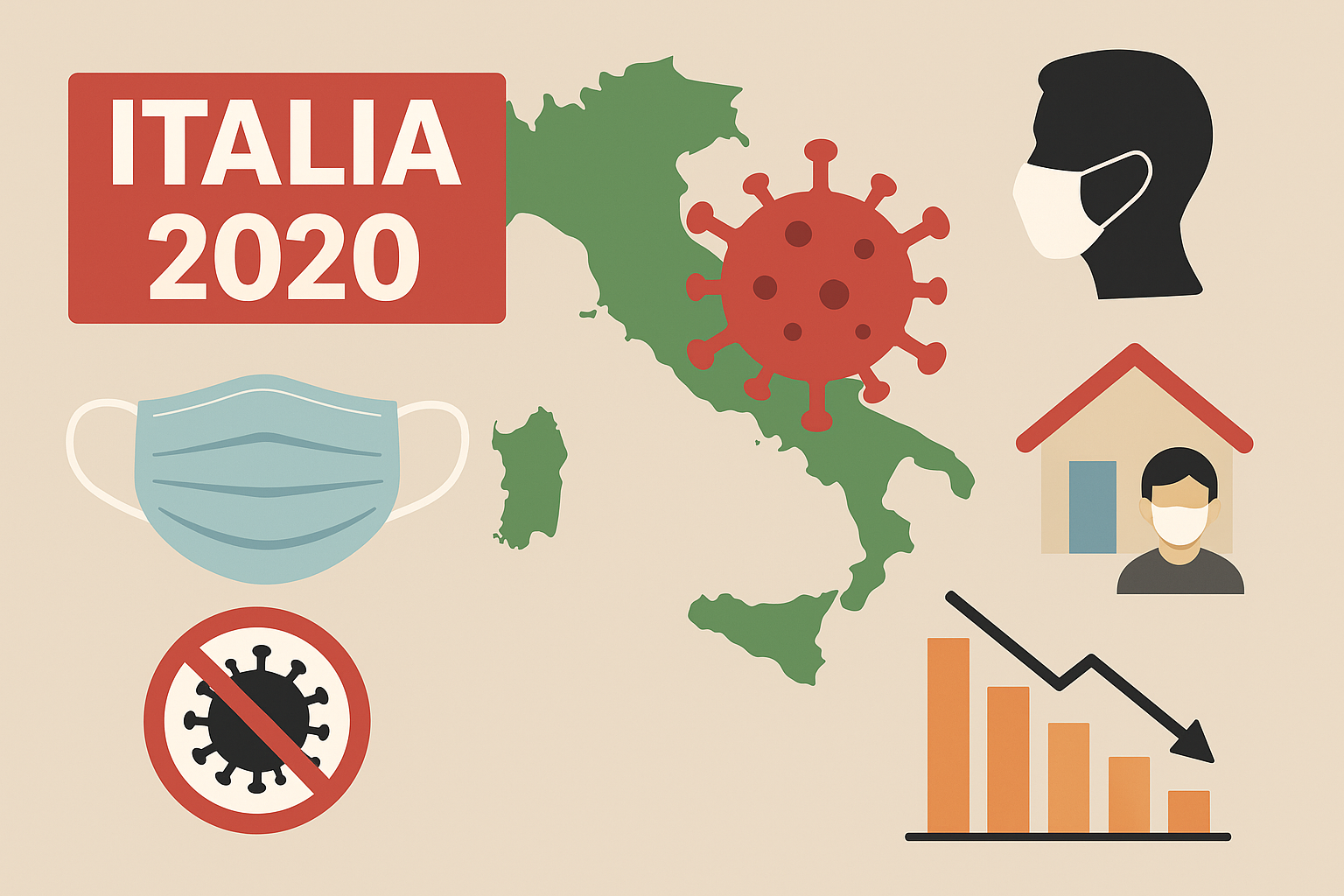
Di Pierdomenico Corte Ruggiero
Sono trascorsi cinque anni dal funesto 2020. L’anno del Covid. Della Pandemia.
Un drammatica emergenza che ha messo a durissima prova tutto il mondo.
L’Italia si è trovata ad affrontare il Covid con una sanità già prossima al collasso. Con una economia fragile. Con pochi mezzi.
Il governo Conte prese i provvedimenti che ritenne necessari.
Dopo cinque anni ora i provvedimenti presi dal governo italiano sono oggetto di analisi e di critica. Con una apposita commissione d’inchiesta parlamentare.
Sicuramente è giusto analizzare e nel caso criticare i provvedimenti presi nel 2020. Allo stesso tempo è evidente il rischio di uso strumentale per fini politici.
Proviamo quindi ad illustrare una cronologia il più possibile asettica. Evitando il tema dei vaccini per i quali è necessaria una preparazione scientifica e medica.
Il 31 gennaio 2020 il governo italiano dichiara lo stato di emergenza nazionale. Pochi giorni dopo, con l’ordinanza 630 della Protezione civile, viene istituito il Comitato tecnico-scientifico (CTS). Il 23 febbraio, il decreto-legge n. 6/2020 fornisce la cornice giuridica per adottare misure straordinarie: è il preludio ai primi Dpcm che restringono la vita sociale e lavorativa.
Dal 4 marzo scuole e università chiudono su tutto il territorio. L’8 marzo scatta la “zona arancione” in Lombardia e in 14 province del Nord, ma è il 9 marzo a segnare la svolta: l’Italia diventa il primo Paese europeo a introdurre un lockdown nazionale, con la campagna “Io resto a casa”.
La Pandemia viene affrontata in tre fasi
1. Contenimento duro (marzo-aprile)
Lockdown totale: spostamenti solo per lavoro, necessità e salute.
Protocolli nei luoghi di lavoro (14 marzo e 24 aprile) con regole su distanziamento, mascherine, sanificazioni e sorveglianza sanitaria.
Sostegni economici: il decreto “Cura Italia” (17 marzo) rafforza il Servizio sanitario nazionale, introduce cassa integrazione straordinaria e indennità per autonomi; l’8 aprile arriva il decreto “Liquidità”, con garanzie statali sui prestiti alle imprese.
2. Riaperture controllate (maggio-settembre)
Dal 4 maggio il Dpcm 26 aprile avvia la cosiddetta “fase 2”: ripartono gradualmente manifattura, cantieri e commercio. Restano obblighi di mascherina e protocolli nei luoghi di lavoro.
In parallelo viene lanciata l’app di tracciamento Immuni, con forti garanzie di privacy. L’uso però resta limitato e il suo impatto concreto si rivela modesto.
3. Convivenza con il virus (ottobre-dicembre)
Con l’autunno la curva dei contagi risale. Il Dpcm del 13 ottobre rafforza l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Dal 3 novembre entra in vigore il sistema a zone (gialla, arancione, rossa), che differenzia le restrizioni in base agli indici di rischio e alla pressione ospedaliera. È la risposta per evitare un nuovo lockdown generalizzato.
La prima ondata primaverile tocca il suo apice il 7 aprile: oltre 130mila casi notificati e quasi 17mila decessi. La discesa prosegue fino all’estate, quando la curva si stabilizza. In autunno, la seconda ondata porta nuovamente a centinaia di morti al giorno, soprattutto tra gli anziani.
Le RSA risultano tra i luoghi più colpiti: un’indagine dell’Istituto superiore di sanità, tra marzo e maggio, segnala gravi criticità in fatto di dispositivi di protezione, tamponi e gestione dell’isolamento.
L’azione del governo ha avuto dei punti di forza
1. Rapidità normativa: in due settimane l’Italia passa da chiusure locali al lockdown nazionale.
2. Protocolli di sicurezza: linee guida chiare per le aziende, che permettono continuità alle filiere essenziali.
3. Sostegni straordinari: iniezione di liquidità, cassa integrazione estesa e rafforzamento del SSN.
4. Sistema a colori: in autunno evita un secondo blocco totale, calibrando le misure sulle singole Regioni.
Ma anche criticità
La Val Seriana: la mancata istituzione tempestiva di una zona rossa tra Alzano e Nembro, a inizio marzo, resta uno dei punti più controversi. Una chiusura anticipata avrebbe forse contenuto il contagio locale.
RSA vulnerabili: mancano piani e forniture mirati nei primissimi mesi, con conseguenze gravi sulle strutture residenziali.
Tracciamento debole: Immuni nasce con un impianto di privacy avanzato, ma senza un’integrazione piena nei sistemi sanitari regionali il suo ruolo resta marginale.
Comunicazione normativa complessa: tra agosto e ottobre il susseguirsi di Dpcm e ordinanze regionali su mascherine, orari e spostamenti crea confusione tra cittadini e imprese.
Ci chiediamo quindi, si poteva fare di più?
Col senno di poi, sì. Tre i punti cruciali:
1. Intervenire prima sui focolai più gravi, come in Val Seriana.
2. Proteggere meglio e subito le RSA, garantendo DPI e tamponi.
3. Rafforzare il testing e il tracciamento, con sistemi più integrati e comunicazione chiara.
Il 2020 è stato l’anno in cui l’Italia ha costruito, quasi dal nulla, un impianto giuridico e organizzativo per fronteggiare una pandemia sconosciuta.
Il Paese ha mostrato capacità di adattamento: lockdown rapido, protocolli condivisi, sostegni massicci e, nella seconda ondata, un modello di restrizioni differenziate che ha permesso di evitare un nuovo blocco totale.
Gli errori non mancano, soprattutto nella protezione delle fasce più fragili e nella gestione dei focolai iniziali.
Ma, date le conoscenze limitate e il tempo compresso, l’Italia ha rappresentato obbiettivamente uno dei primi laboratori mondiali nella gestione di una crisi sanitaria senza precedenti.
RIPRODUZIONE RISERVATA ©

