07 Aprile 2025
Rebecca Solnit e il mansplaining: quando le donne sono marginalizzate e delegittimate
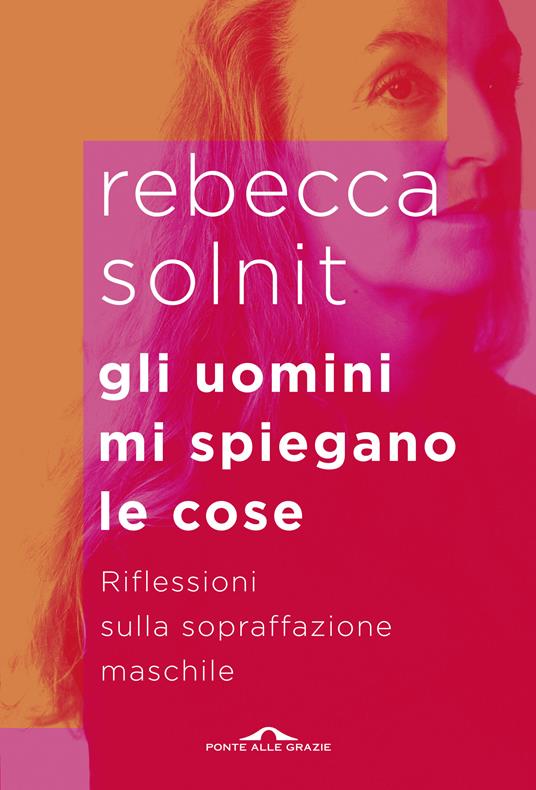
Di Maddalena Celano
(…) Ancora giovanissima, quando appena iniziavo a capire cosa fosse il femminismo e perché fosse indispensabile, avevo un ragazzo il cui zio era un fisico nucleare. Una volta, a Natale, si era messo a raccontare – come se si fosse trattato di un argomento leggero, divertente – che nella sua comunità suburbana di costruttori di bombe una vicina era uscita di casa correndo, nuda e in piena notte, urlando che il marito voleva ucciderla. Come faceva a sapere, gli domandai, che il marito non stesse davvero cercando di ucciderla? Lui, paziente, spiegò che erano una coppia borghese e rispettabile. Dunque, un marito con intenzioni omicide non costituiva una spiegazione plausibile perché quella donna scappasse di casa strillando che lui stava tentando di ammazzarla. Al contrario, probabilmente lei era matta. Anche per ottenere un’ ordinanza restrittiva (strumento legale piuttosto recente) occorre acquisire una credibilità per convincere i giudici che un uomo rappresenta una minaccia e quindi per far sì che la polizia la faccia rispettare. E comunque le ordinanze restrittive spesso non funzionano. La violenza è un modo per azzittire le persone, per negargli voce e credibilità, per affermare il proprio diritto di controllare il diritto altrui di esistere. Negli Stati Uniti ogni giorno all’ incirca tre donne vengono assassinate dal proprio compagno o da un ex: per le donne incinte di questo Paese rappresenta una delle principali cause di morte. Al cuore della lotta femminista affinché lo stupro, il date rape, la violenza sessuale coniugale, la violenza domestica e le molestie sessuali sul luogo di lavoro assumessero lo statuto giuridico di reati c’è stata la necessità di assicurare credibilità e ascolto alle donne.
Sono propensa a credere che le donne abbiano acquisito lo status di esseri umani quando si è cominciato a prendere sul serio questo genere di atti, quando i gravi problemi che ci frenano e ci uccidono sono stati perseguiti penalmente, dalla metà degli anni Sessanta in poi: ossia, molto tempo dopo la mia nascita. E a chiunque stia per sostenere che le intimidazioni sessuali in ambito lavorativo non sono una questione di vita o di morte, voglio ricordare che a quanto pare il caporale di Marina Maria Lauterbach , vent’ anni, è stata uccisa una sera d’ inverno da un suo collega di grado superiore mentre era in attesa di testimoniare contro di lui perché l’ aveva stuprata. I resti carbonizzati della ragazza, che era incinta, sono stati ritrovati nel braciere in muratura nel guardino dell’ uomo. Sentirsi dire, in maniera categorica, che lui sa di cosa sta parlando mentre lei non sa, anche quando è un elemento di poco conto all’ interno di una conversazione, perpetua la bruttezza di questo mondo e ne soffoca la luce. Dopo la pubblicazione del mio libro Wanderlust nel 2000, mi sono scoperta più capace di resistere alla prepotenza che mi vorrebbe dissuadere dal mio modo di percepire e interpretare le cose. Più o meno in quel periodo, in un paio di occasioni ebbi da obiettare sul comportamento di un uomo, con l’ unico risultato di sentirmi dire che le cose non erano andate affatto come dicevo io, che era la mia opinione soggettivo, che le cose me le immaginavo, che ero nervosa e in mala fede: insomma, mi comportavo da femmina. Per buona parte della mia vita avrei dubitato di me e avrei fatto marcia indietro. Possedere una reputazione pubblica come saggista storica mi aiutò a restare salda nella mia posizione, ma una tale iniezione di fiducia è privilegio di poche donne, e in questo pianeta di sette miliardi di individui miliardi di donne si sentiranno dire che non sono testimoni attendibili della loro stressa vita, che la verità non gli appartiene, né ora né mai. Ciò va ben oltre gli uomini che spiegano le cose, e appartiene allo stesso arcipelago di arroganza. Gli uomini mi spiegano le cose, tuttora. E nessun uomo si è mai scusato per avermi spiegato, a torto, cose che io so e che loro non sanno. Non è ancora successo, ma potrebbe, visto che secondo le tavole attuariali forse mi restano più o meno altri quarant’ anni di vita. Anche se di certo non mi faccio illusioni. (…)
Rebecca Solnit, Gli Uomini mi spiegano le cose, Ponte alle Grazie, Milano,2024, pp. 13-15.
Rebecca Solnit, con il suo stile acuto e penetrante, ha contribuito in modo significativo al dibattito femminista contemporaneo, fornendo concetti che sono entrati nel linguaggio comune, primo fra tutti il “mansplaining”. Il termine, pur non coniato direttamente da Solnit, deriva dal suo celebre saggio “Gli uomini mi spiegano le cose” e descrive un fenomeno tanto comune quanto insidioso: uomini che si sentono in diritto di spiegare alle donne concetti che queste padroneggiano già, a volte persino meglio di loro.
Devo ammettere che, inizialmente, ho sottovalutato questo saggio pregiudizialmente. Pensavo fosse un’analisi fin troppo concentrata su episodi apparentemente marginali. Eppure, una volta immersa nella lettura, mi sono sentita profondamente rispecchiare in ogni pagina. La sua descrizione della sistematica delegittimazione delle donne e della loro esperienza è qualcosa che, come articolista e saggista, vivo quotidianamente. Dalle interruzioni e correzioni paternalistiche ai tentativi di minare la credibilità, fino alle vere e proprie aggressioni online da parte di misogini militanti come gli incel e gli MRA (Men’s Rights Activists), il fenomeno descritto da Solnit si manifesta con una brutalità che va ben oltre il semplice fastidio quotidiano. In particolare, ho trovato inquietante e fin troppo familiare il modo in cui l’autrice racconta le violenze e le minacce subite da giornaliste e scrittrici, spesso oggetto di campagne d’odio organizzate con l’intento di silenziarle. Le violenze contro le giornaliste e le articoliste rappresentano una delle manifestazioni più evidenti della misoginia strutturale che pervade il mondo dell’informazione. Minacce, intimidazioni, aggressioni fisiche e campagne d’odio online sono strumenti utilizzati sistematicamente per ridurre al silenzio le donne che osano esprimersi pubblicamente. Dai regimi autoritari alle democrazie occidentali, il fenomeno assume connotazioni diverse, ma il denominatore comune resta l’attacco alla credibilità e all’incolumità delle giornaliste.
Secondo il rapporto dell’UNESCO del 2021, il 73% delle giornaliste ha subito minacce, molestie o violenze online a causa del proprio lavoro. La situazione diventa ancora più critica quando le giornaliste trattano temi come i diritti delle donne, la corruzione o la politica.
Reporters Sans Frontières (RSF) segnala che, negli ultimi dieci anni, sono aumentate le aggressioni fisiche contro le giornaliste, specialmente in contesti di protesta o durante la copertura di conflitti armati. Nel 2022, la giornalista palestinese Shireen Abu Akleh è stata uccisa mentre svolgeva il suo lavoro, in un episodio che ha suscitato indignazione internazionale.
L’odio digitale è una delle forme più diffuse di violenza contro le giornaliste. Commenti sessisti, minacce di stupro, diffusione di dati personali (doxxing) e campagne di disinformazione volte a screditarle sono pratiche comuni.
Un caso emblematico è quello della giornalista britannica Carole Cadwalladr, vincitrice del Premio Pulitzer, che ha subito una feroce campagna d’odio online per aver denunciato lo scandalo Cambridge Analytica. Anche in Italia, giornaliste come Federica Angeli, che ha indagato sulla mafia romana, hanno ricevuto minacce di morte e necessitano di scorta per la loro sicurezza.
Dagli attacchi verbali alle aggressioni fisiche
Se l’odio digitale è già un’arma pericolosa, non mancano gli episodi di violenza fisica contro le giornaliste. Durante le manifestazioni del movimento “Black Lives Matter” negli Stati Uniti, diverse reporter sono state aggredite dalla polizia o da manifestanti violenti. In America Latina, il Messico è uno dei paesi più pericolosi per le giornaliste: nel 2021, almeno 10 professioniste dell’informazione sono state assassinate.
Le violenze contro le giornaliste e le articoliste non sono solo attacchi personali, ma colpiscono la libertà di stampa e il diritto all’informazione. Organizzazioni come il Committee to Protect Journalists (CPJ) e RSF continuano a denunciare questi abusi, chiedendo maggiore protezione per le professioniste dell’informazione.
Affrontare la misoginia nel giornalismo significa garantire che le donne possano esercitare la loro professione senza paura di rappresaglie. Il giornalismo femminile non deve diventare sinonimo di coraggio, ma di normalità. E fino a quando ciò non accadrà, ogni parola scritta da una giornalista sarà un atto di resistenza.
Il Mansplaining come Strumento di Svalutazione
Molti potrebbero liquidare il mansplaining come un problema minore, un’inezia rispetto alle forme più gravi di discriminazione di genere. Eppure, la sua radice è la stessa: l’incapacità di riconoscere alle donne una piena soggettività intellettuale. Questo atteggiamento si riflette su una scala più ampia quando le donne denunciano abusi e violenze e si ritrovano costantemente a dover dimostrare di essere credibili, come se la loro parola valesse meno a prescindere.
Nei tribunali, nelle interviste, nella vita quotidiana, il pregiudizio sulla scarsa attendibilità delle donne si manifesta in mille modi. Dal processo mediatico sulle vittime di violenza sessuale – in cui si analizzano più i loro comportamenti che quelli degli aggressori – fino alla difficoltà delle donne a essere riconosciute come esperte nei loro settori, il sistema continua a riprodurre una dinamica di sfiducia strutturale. Il mansplaining, dunque, non è un evento isolato, ma parte di un continuum di pratiche che minano la voce femminile nello spazio pubblico.
La Violenza e la Negazione della Credibilità
Nel racconto di un episodio avvenuto quando era giovane, Solnit descrive la reazione di uno scienziato che sminuisce le urla di una donna che fugge nuda in strada per salvarsi dal marito violento. Il motivo? Erano una “coppia rispettabile”, quindi lei doveva essere pazza, non in pericolo. Questa narrazione è la stessa che si ripete ogni volta che una donna denuncia una violenza e viene costretta a dimostrare di essere una vittima credibile.
Negli Stati Uniti, ogni giorno tre donne vengono uccise dal proprio partner o ex, e per le donne incinte la violenza domestica è una delle principali cause di morte. La battaglia femminista per il riconoscimento legale di reati come lo stupro coniugale, la violenza domestica e le molestie sul lavoro è stata, ed è tuttora, una battaglia per il diritto delle donne a essere ascoltate e credute. Solnit evidenzia che il semplice diritto delle donne a essere considerate testimoni attendibili della propria vita è stato ottenuto solo a partire dagli anni Sessanta.
La Circolazione delle Idee Femministe: Un Processo Collettivo
Uno degli aspetti più interessanti dell’opera di Solnit è che, pur essendo una delle voci più influenti del femminismo contemporaneo, non si arroga il merito esclusivo delle idee che diffonde. La sua scrittura riflette la natura collettiva del femminismo: le idee non appartengono a singoli individui, ma circolano, si evolvono e si arricchiscono grazie alle lotte e alle riflessioni di molte donne.
Solnit ha aperto un discorso che altre hanno portato avanti, ampliandolo con prospettive che forse lei stessa non aveva considerato. Questo è un tratto distintivo del pensiero femminista: non esistono dogmi né singole eroine, ma un movimento corale in continua trasformazione.
L’eleganza e l’ironia con cui Rebecca Solnit sviscera le assurdità del maschilismo contemporaneo rendono i suoi saggi non solo illuminanti, ma anche provocatori. Il suo lavoro è un invito a riflettere su come, ancora oggi, le donne debbano lottare per essere ascoltate e credute. Per chiunque voglia comprendere meglio le dinamiche del potere linguistico e culturale che alimentano la disuguaglianza di genere, questa raccolta è una lettura imprescindibile.
Il femminismo non è solo una battaglia per i diritti, ma anche per il riconoscimento della voce e dell’esperienza delle donne. E Solnit, con la sua prosa incisiva, ci ricorda che ascoltare è il primo passo per cambiare il mondo.

